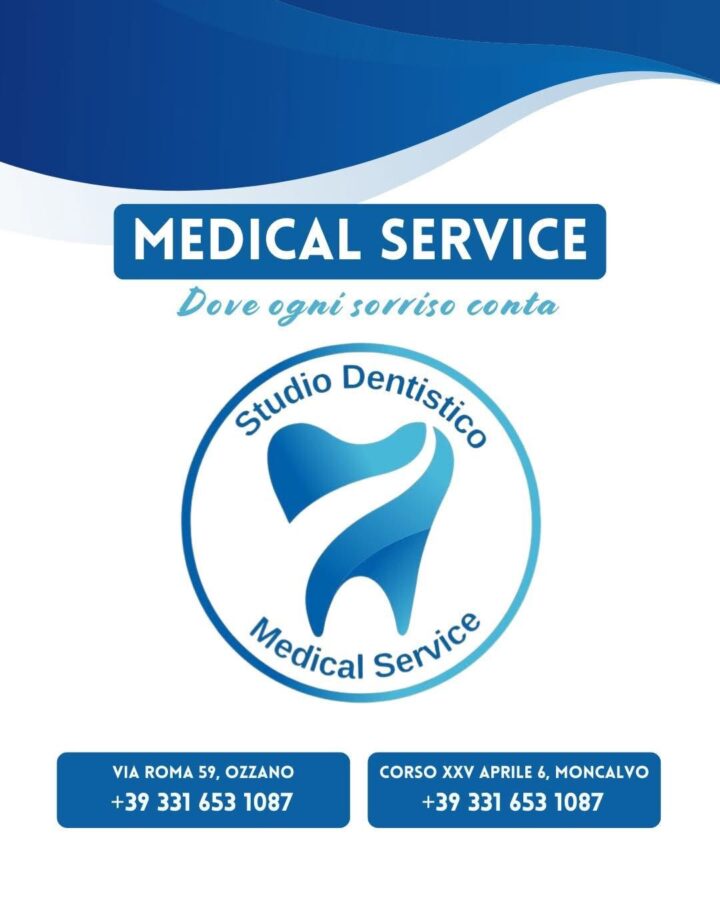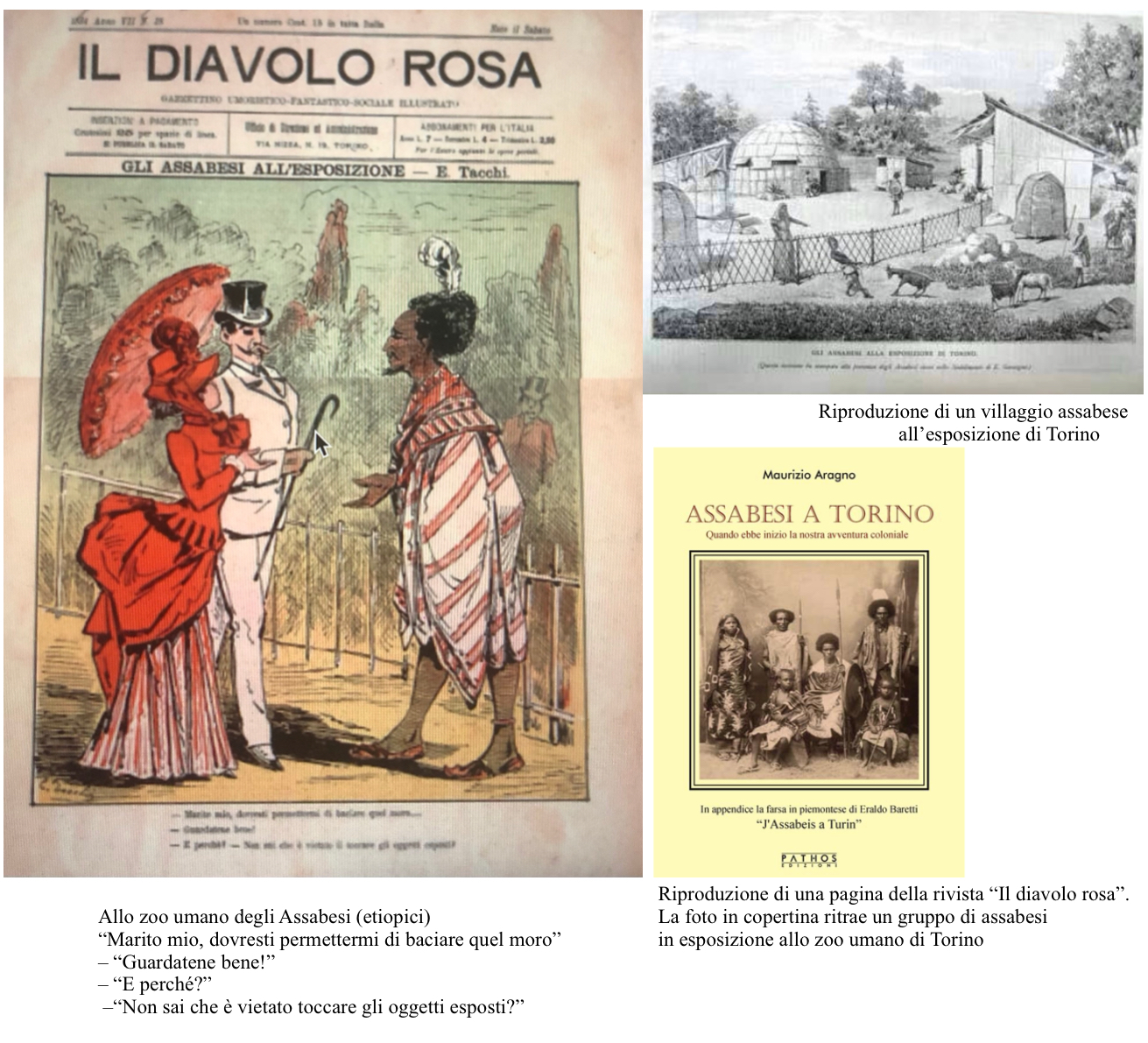(M.Iar.) Ratificare e porre in esecuzione il Trattato che istituisce la Comunità Europea di Difesa, con i Protocolli e gli Accordi internazionali firmati a Parigi. E’ l’oggetto di un disegno di legge presentato dal Senato dal Gruppo di Italia Viva, primo firmatario Enrico Borghi (ma condiviso anche da Renzi, Paita, Scalfarotto, Fregolent, Musolino e Sbrollini). Si tratta di un’iniziativa legislativa che è finalizzata a far proseguire il progetto di una Comunità di Difesa con un Trattato già approvato all’inizio degli anni Cinquanta, in piena Guerra Fredda, dai parlamenti di Germania Ovest, Belgio, Olanda e Lussemburgo – ovvero 4 sei 6 Stati che avevano dato vita alla Ceca per il carbone e l’acciaio – ma venne affossato dal rigetto dell’Assemblea Nazionale francese il 30 agosto 1954, mentre in Italia il disegno di legge presentato dal governo Scelba alla Camera dei deputati il 6 aprile 1964 enne ritirato il 22 giugno 1955. Ma, come ha sostenuto Enrico Borghi, il Trattato è rimasto ‘congelato’ e adesso – con una testo che è ampiamente provocatorio ma fondato su basi giuridiche – in un contesto particolare internazionale, ne viene proposta la ripresa dell’iter legislativo. Motivazioni ed analisi le affidiamo alla penna di Enrico Borghi, primo firmatario, componente della Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama e del Copasir, che aveva anticipato il contenuto del disegno di legge in occasione della presentazione, a cura di Italia Viva Valenza, del suo libro ‘Sotto Attacco’ avvenuta al Centro Comunale di Cultura. Nell’intervento che segue:
di Enrico Borghi

Perchè “resuscitare” un trattato internazionale come la Comunità Europea della Difesa dopo tanti anni? La domanda è più che legittima, e necessita di un inquadramento storico e geopolitico.
Che parte da una constatazione: è inutile girarci attorno, oggi viviamo in un mondo più pericoloso che nel recente passato.
I “flash point” hanno tanti nomi: guerra russa in Ucraina, espansione della Cina come concorrente/avversario dell’Occidente (che a sua volta sta mutando pelle al proprio interno con la presidenza Trump), Corea del Nord, Iran, Gaza e Cisgiordania, terrorismo jihadista, Africa. I “flash point” futuri assumono i contorni geografici della Groenlandia, di Taiwan, dell’est Europa, del Venezuela e del Mar Cinese Meridionale.
In questa cornice, gli USA ritengono che la Cina voglia rubar loro il posto nel ruolo di potenza globale dominante, e per questo fanno del Pacifico l’oceano globale come lo fu l’Atlantico nel Novecento. Pechino, dal canto suo, ha avviato un obiettivo strategico-militare di lungo periodo che supporta una politica di riarmo che la vede spendere per armi nel 2021 il 63% in più rispetto al 2013, giungendo ad avere in modo stabile il secondo budget militare più ingente del mondo (1.560 miliardi di yuan, circa 220 miliardi di dollari), secondo solo alla Difesa americana che ha un bilancio di 858 miliardi di dollari all’anno.
Pechino punta a una sorta di propria “dottrina Monroe” sul continente asiatico e sull’area del Pacifico (in un’area dove si produce il 50% del PIL mondiale e dove sono presenti democrazie o sistemi politici che hanno deciso di stare politicamente e militarmente dalla parte dell’Occidente).
L’obiettivo esplicito della Cina di Xi, convinto assertore della superiorità del suo modello politico come si evince dalle conclusioni del XX congresso del PCC nell’ottobre 2022, è quello di dimostrare al mondo che l’efficienza del modello comunista e nazionalista cinese porta alla sua superiorità rispetto a tutti gli altri, per puntare all’egemonia del secolo.
Gli Stati Uniti non possono accettare il declassamento, e si riorientano (fin dai tempi di Barack Obama) strategicamente verso l’Asia, spostando l’asse centrare della politica americana sul Pacifico.
E’ un effetto spiazzamento per noi Europei, che ci eravamo abituati allo zio Sam come fornitore di sicurezza e di difesa dal 1945 in poi.
Guardiamoci attorno: la presenza di truppe americane in Europa è passata dalle 400.000 unità dei tempi della guerra fredda agli 80.000 attuali, 20.000 dei quali stanziati sul fianco est.
Nei giorni scorsi Trump ha annunciato il ritiro di 700 militari americani dalla Romania, il fronte NATO più vicino al teatro ucraino dove si combatte dal 24 febbraio 2022 una guerra anche per nostra interposta presenza.
Tutto questo richiama inevitabilmente l’Europa a fare il salto di qualità, la prova di maturità, l’assunzione di responsabilità verso una politica comune di sicurezza e di difesa.
Tutti questi fattori, infatti (ai quali si potrebbe anche aggiungere la nascita della partnership securitaria tra USA, Regno Unito e Australia denominata AUKUS e la prospettiva della cosiddetta “Nato asiatica” elaborata dagli Stati Uniti con Giappone e Corea del Sud pronti a lasciare alle ortiche le ferite della Seconda Guerra Mondiale di fronte alla minaccia crescente di un allineamento tra Pechino, Mosca e Pyongyang) spingono verso una maggiore assunzione di responsabilità sul versante europeo nella costruzione di una più incisiva politica estera e di sicurezza comune, fondata sul concetto di autonomia strategica e possibilità di costituire uno strumento di difesa comune.
E’ qui che arriviamo alla CED. I padri fondatori dell’Europa -Jean Monnet e Alcide De Gasperi in testa- avevano immaginato all’inizio degli anni ’50 una “Comunità Europea della Difesa” come secondo polmone dell’integrazione europea insieme alla “Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio-CECA” che poi evolverà in Comunità Economica Europea-CEE e poi in Unione Europea.
Il 27 maggio 1952 , sei paesi europei (Italia, Francia, Germania Ovest, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) firmarono il “Trattato istitutivo della Comunità Europea della Difesa”, al fine di promuovere la formazione di una difesa europea sovranazionale nel suo carattere, con istituzioni comuni, comuni forze armate e un budget comune. La CED si immaginava operate all’interno del sistema di sicurezza transatlantico inaugurato con la nascita della NATO nel 1949. La grandeur nazionalista francese unita al populismo comunista influenzato da Stalin affossò in Francia la ratifica del trattato, che però è stato ratificato da quattro paesi tra cui la Germania .
Ecco l’uovo di Colombo, allora: proporre anche la ratifica dell’Italia, per stimolare la Francia a chiudere il cerchio e creare a questo punto il “nocciolo duro” europeo in materia di difesa e sicurezza in grado di evitare che la sfida internazionale della sicurezza significhi il ritorno agli anni ’30 del Novecento, ovvero il riarmo nazionale.
L’idea dei nostri Padri era quella per la quale i popoli europei non si facessero più la guerra tra loro, ma si potessero difendere insieme contro eventuali nemici.
Ad ostacolare questa idea fino a oggi c’è stata la riluttanza rispetto alla cessione di sovranità nazionale in vantaggio di una sovranità comune europea, come peraltro già accaduto in altri settori e funzioni (dalla moneta unica alle politiche commerciali fino alla mutualizzazione del debito post- Covid).
Oggi il nuovo quadro geopolitico fa affiorare l’esigenza di una emancipazione europea, censo risaltare ancor più la correttezza e la lungimiranza dello sguardo dei padri fondatori.
Serve la politica per governare la Storia. E la CED lo è. Questa è una delle ragioni di fondo per l’istituzione di una forza europea multinazionale e interforze pronta ad essere impiegata in operazioni specifiche e in teatri dove si esige la presenza di forze militari di interposizione e di pace.
Inutile farsi illusioni: diverse minacce incombono sul nostro continente, da quelle di natura terroristica -ibrida e asimmetrica- a quelle di carattere più “tradizionale”, legate al ritorno dell’imperialismo nella Storia.
Solo se l’Unione europea, con il meccanismo della cooperazione rafforzata -e la CED è il cuore di questo strumento- assurge a rango di potenza mondiale, in grado di sviluppare piani strategici, militari e operativi finalizzati alla gestione delle crisi, potremo essere in grado di sostenere e difendere i valori di pace, democrazia, libertà e uguaglianza su cui noi siamo fondati, ma che altri ritengono siano un fastidioso orpello del passato.
Oggi è in gioco la credibilità e l’identità stessa dell’Unione Europea, e del nostro futuro. Questo è il senso della ratifica di questo trattato internazionale.