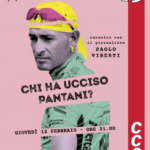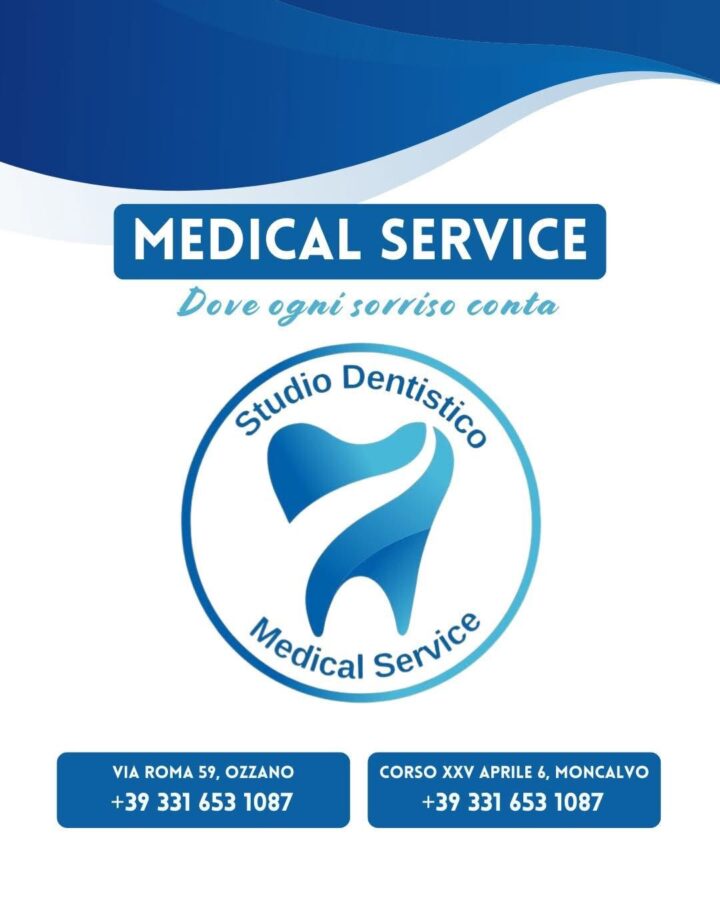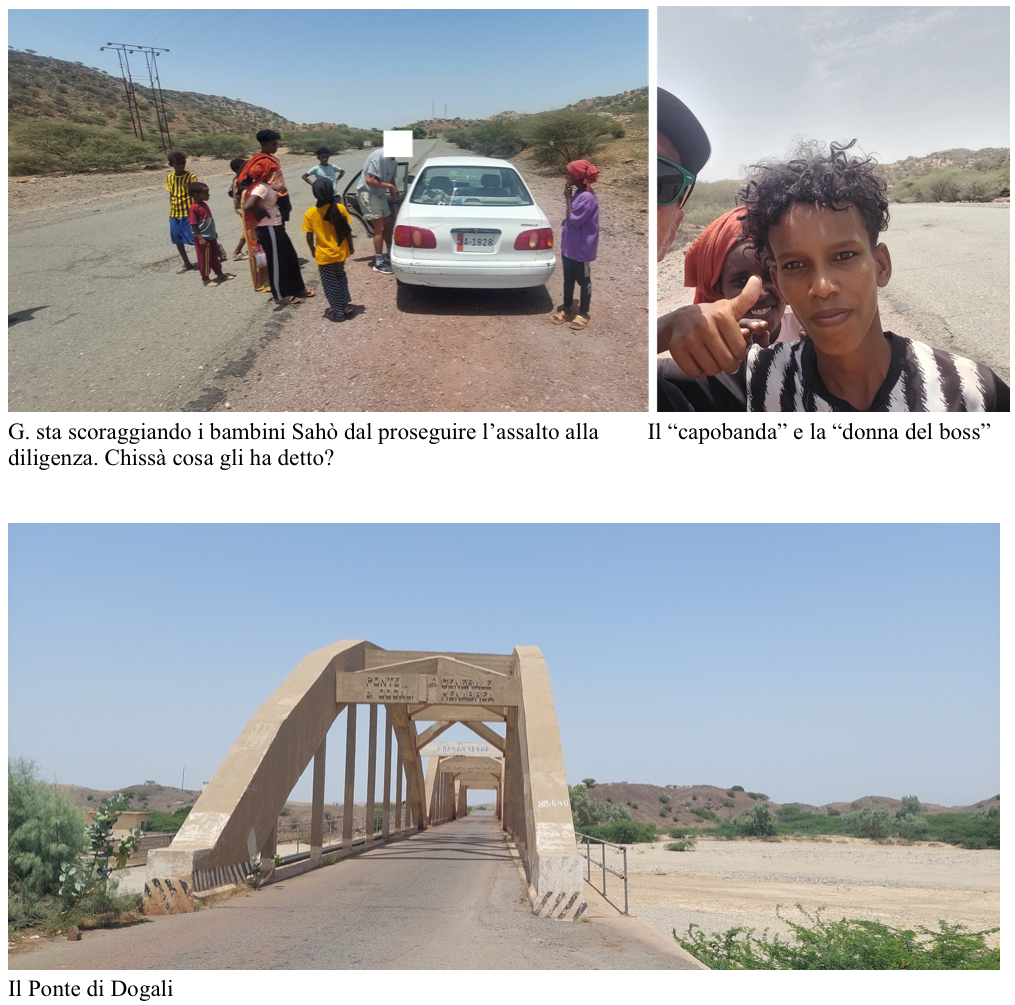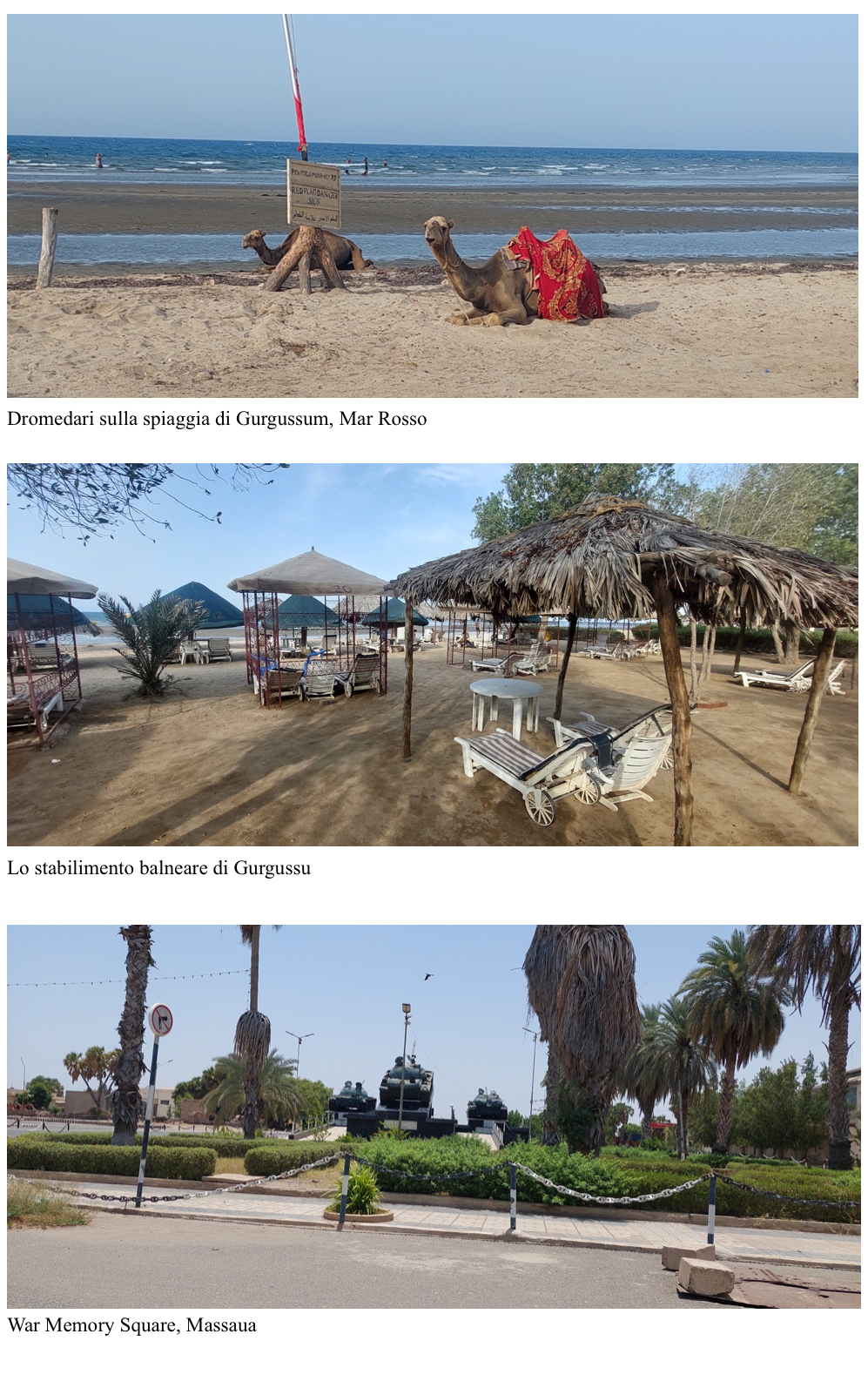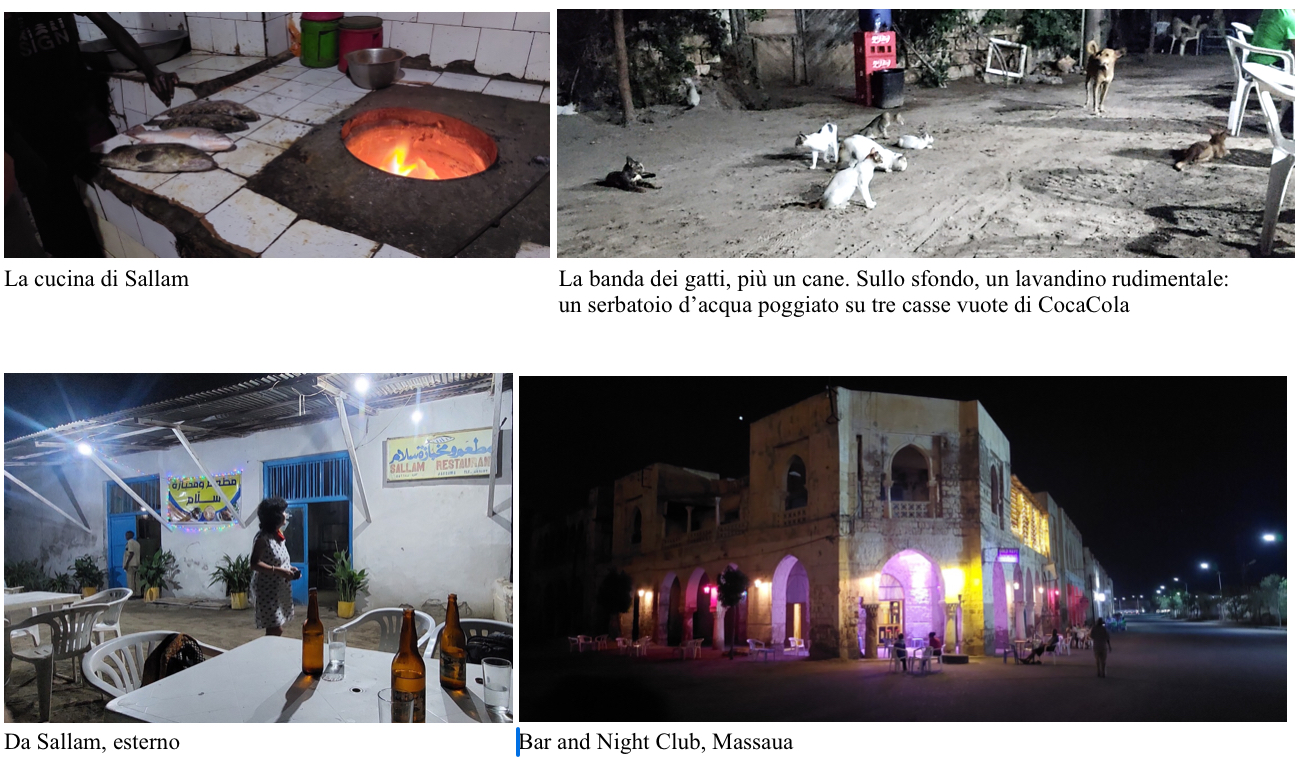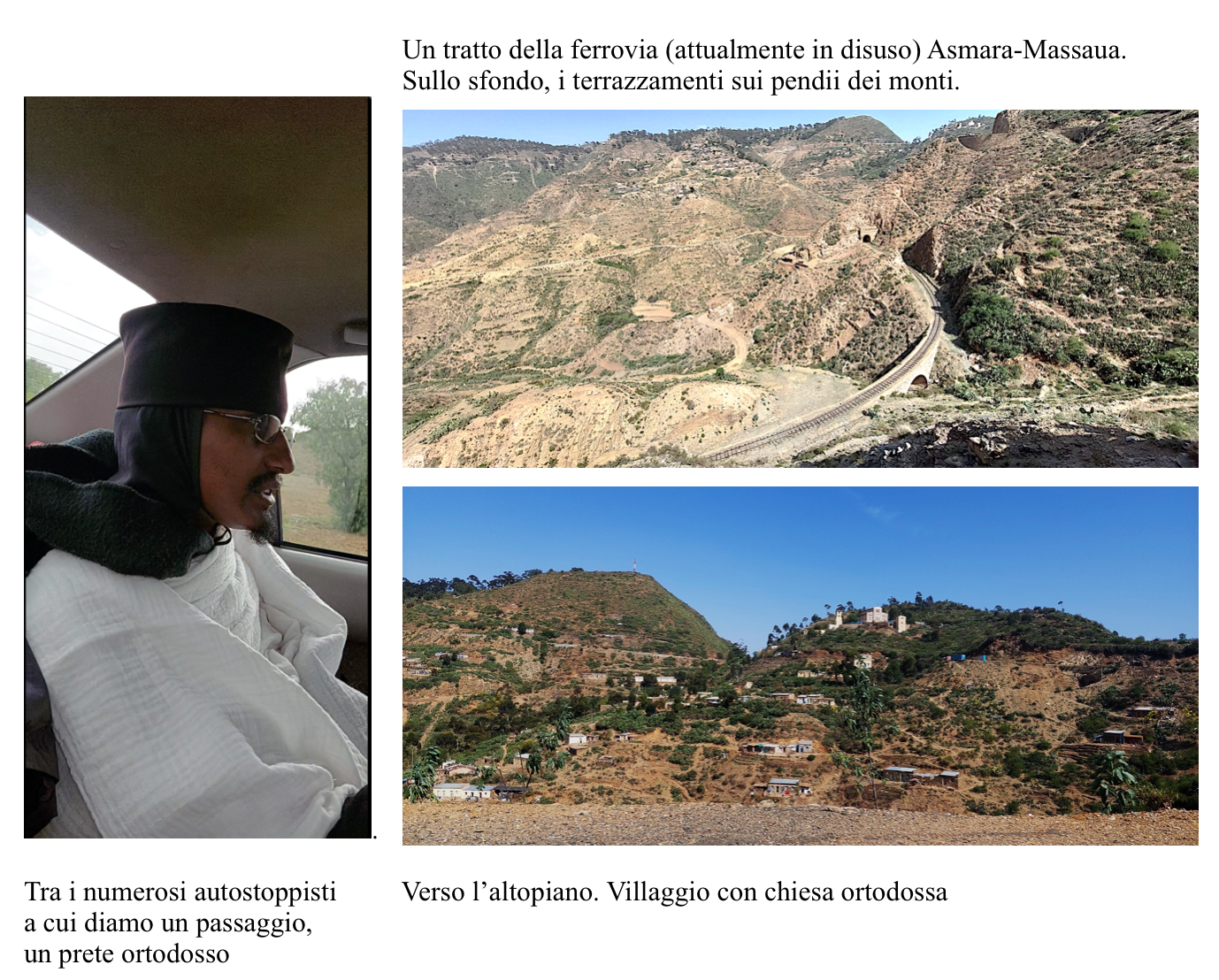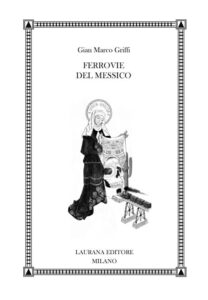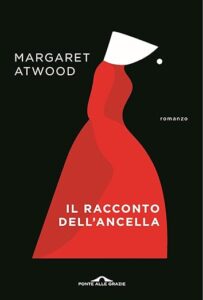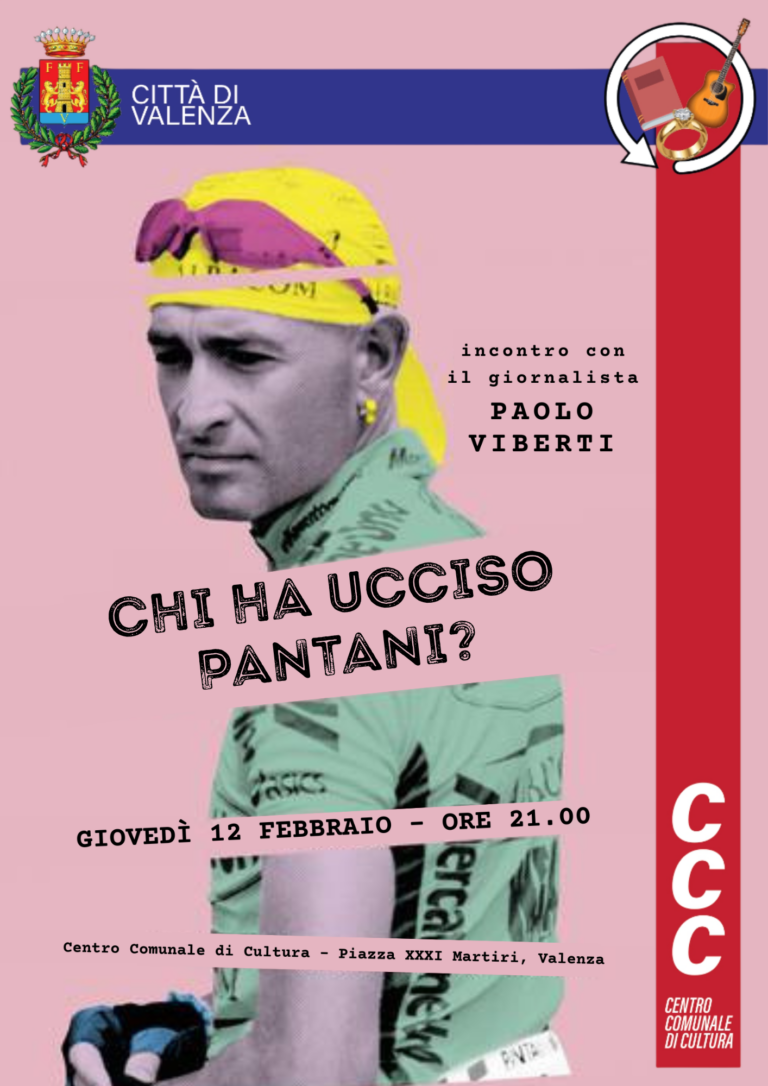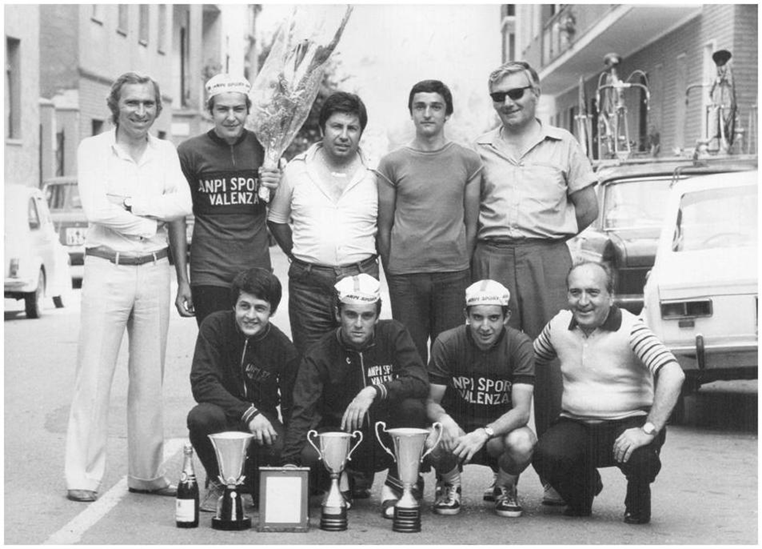di Maria Antonella Pratali
Diciannovesima puntata – Qualche cenno di storia (anche nostra)

Il toponimo “Eritrea” (dal greco antico ‘Erythraia’, Terra del Mar Rosso) fu assegnato a quella parte del continente africano proprio da noi italiani, in modo del tutto arbitrario, per unificare nominalmente un insieme di territori e di varietà culturali ed etniche, dalla costa sul Mar Rosso all’altopiano di Asmara, che improvvisamente si ritrovarono ad avere un minimo comune denominatore, il dominio coloniale italiano.
I confini erano labili, in quanto si trattava di strappare via via più territori all’Etiopia; tutte le etnie artificialmente unificate divennero ‘eritrei’ per nostra volontà. Eppure il fenomeno del colonialismo italiano è stato a poco a poco rimosso dai nostri libri di storia, o al massimo liquidato con qualche riga.
“Tutti i momenti ‘importanti’ del [nostro] Paese sono stati letti e riletti nel corso del tempo. Anzi no, quasi tutti. C’è un aspetto della storia italiana che […] non è stato ripreso a livello pubblico […] Si tratta del colonialismo italiano”. Così si legge nell’introduzione dell’interessantissimo volume “Noi però gli abbiamo fatto le strade” di Francesco Filippi, edito da Bollati Boringhieri nel 2021.
Sebbene sia durato circa ottant’anni, dal 1882 al 1960, il colonialismo italiano pare essere stato quasi cancellato dalla nostra memoria collettiva. Se lo si ricorda, al massimo lo si circoscrive al fascismo, e “l’immagine dei gas e delle violenze contro la popolazione civile” finisce nel triste elenco dei crimini fascisti, e lì viene isolata. Ma il mito degli “italiani, brava gente” viene sfatato, documenti alla mano, da intellettuali e storici già dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso. Nel 2005 Angelo Del Boca pubblica con Neri Pozza “Italiani, brava gente? Un mito duro a morire”, citando i tentativi di invasione dell’Etiopia negli anni Novanta dell’Ottocento, la guerra per la Libia (1911-12), le violenze contro le popolazioni civili; e sottolineando sostanzialmente una certa continuità nella politica coloniale italiana, sebbene la svolta del fascismo abbia accentuato, ma non inventato, le violenze e i crimini a scapito degli indigeni.
Si può dire che Mussolini erediti e continui l’opera dei governi liberali.
Nel 1929 Rodolfo Graziani guida le ultime fasi delle sanguinose repressioni nei territori che verranno poi rinominati nel toponimo collettivo ‘Libia’, con deportazioni in campi di concentramento all’uopo organizzati.
L’Etiopia figura tra le “promesse non mantenute” dei governi liberali, e il duce si presenta come il “vendicatore di Adua”. Conquistata Addis Abeba (toponimo amarico che significa ‘Nuovo Fiore’), Vittorio Emanuele III diventa re-imperatore. L’Abissinia viene narrata con tutti gli stereotipi europei legati all’Africa ‘nera’, con tutto il disprezzo per abitanti considerati subumani, destinati, quindi, a essere sottomessi a una legislazione razzista in un regime di apartheid. Pur essendo un periodo limitato a soli cinque anni (1936-1941), l’invasione dell’Etiopia è l’evento che è rimasto più impresso (o quanto meno non del tutto dimenticato) nella storia coloniale d’Italia.
(Continua. Gli “zoo umani”, allestiti nelle principali città italiane; la creazione del toponimo Abissinia; l’epopea coloniale continua sotto il fascismo)