di Giorgio Ricci
Quando entro nel cimitero della mia città svolto a sinistra dopo nemmeno cinque metri e mi inoltro dove
si apre uno spazio che si potrebbe dire infonda serenità: un contorno di antiche tombe di famiglia e file di
lapidi nella terra, tutte allineate, piuttosto recenti, me lo dicono le date incise nel marmo. In genere mi
appoggio al muro esterno di una cappella che, come tante altre, sembrano innalzarsi alla rinfusa, poi
guardo a terra, a un tappeto di edera, e sorrido a Grazia, le sorrido perché non potrei fare altrimenti a lei
che ha sempre sorriso nella sua vita e che ora lo fa dalla foto sulla lapide.
Niente, continua a sorridere anche se è morta a quarantasei anni.
Era una cosa, quella di morire così giovani, che nell’estate del 1978, la più divertente della mia vita, non
mettevamo in conto, un po’ perché una persona di quarantasei anni, età di alcuni dei nostri genitori, ci
sembrava non dico vecchia ma almeno datata, un po’ perché alla morte non guardavamo proprio. Come ci si poteva pensare? Quando sghignazzi tutto il giorno non puoi rivolgerti a vicende tanto tristi, che
sembrano così lontane, anzi proprio inesistenti. Anche la morte di un nonno, come capitò a me nel
settembre di quell’anno, non veniva catalogata come un triste addio, ma piuttosto come una cosa che
capita, un intoppo neanche tanto grave, la fine naturale di un lungo percorso.
Tornando a Grazia, che continua a sorridermi dalla lapide come se niente fosse – quasi che anche per lei la
morte sia stata un intoppo nemmeno tanto grave – con i suoi quindici anni da compiere a dicembre era la
più giovane del gruppo, al punto da diventarne una mascotte, lei che era sempre pronta alla battuta, alla
risata che ne conseguiva, al prendersi in giro con la sua erre così arrotolata che a volte sgommava a metà
frase.
Anche la sua voce sorrideva, parlava e da lei fuoriusciva gioia.
Le volevamo tutti bene.
Ogni volta che faccio visita al cimitero il mio tour (se proprio vogliamo chiamarlo così) parte dalla Grazia
ancor prima di passare dai miei genitori, dai quattro nonni, da tre zii. Mento a me stesso dicendomi che lei sta subito lì, basta girare a sinistra dopo cinque metri, è così comodo raggiungerla. Le motivazioni non
sono nemmeno quelle derivanti da un flirt giovanile o da un amore non corrisposto. Era un’amica, faceva
parte come me di una compagnia che, almeno per il sottoscritto, di così belle non ne avevano mai fatte e
non ne avrebbero fatte più, ed è morta a quarantasei anni. Mi faccio bastare queste tre ragioni, e poi non è nemmeno triste passare da lei, lei che sorride come se lo facesse in piazza Fogliabella, durante
l’irripetibile estate del 1978.
Anche per quella volta, in quella piccola porzione della nostra vita, nessuno avrebbe potuto dichiarare a
chi e perché fosse venuto in mente di trovarci là, sia nei pomeriggi caldissimi che durante le dolci serate,
in una piazza tutt’altro che bella, contornata da palazzi come tanti ne erano sorti in quel periodo, al suo
centro un giardinetto con aiuole, alcuni alberi e un paio di panchine. Faceva parte della nuova periferia
della città, quella dove fino a pochi anni prima c’erano solo dei campi: un quartiere apparentemente nato
dal nulla, con tanto di chiesa e di centro sportivo, un bar con un nome proiettato nel futuro, a due passi dauna circonvallazione non ancora terminata.
Tutto qui.
Ma a noi appariva meravigliosa, anche se annoverava una Simca 1000 verde bottiglia tra le macchine
parcheggiate dai residenti (e chi ha ben chiaro come fosse la linea di una Simca 1000 sa di che cosa
parlo); meravigliosa, anche se, seduti nel dehors del bar 2000, a turno venivamo attaccati, tutti i pomeriggi
e sempre a sorpresa, da Loreto (o Pepito secondo il momento), il pappagallo multicolor in dotazione al
locale che si arrampicava silenziosamente sulla sedia, e ora che la vittima di turno se ne accorgeva era
sempre troppo tardi, la bestiola aveva già raggiunto la spalla e cominciava ad azionare un famelico becco
sulla maglietta, su un lobo, tra i capelli, mentre gli altri, che avevano taciuto l’arrivo del pennuto, ridevano
e seguitavano a succhiare ghiaccioli alla menta; meravigliosa anche quando una sera, allo scoccare della
mezzanotte, l’inquilino del primo piano, infastidito dai nostri schiamazzi, era uscito sul balcone appena
sopra il bar e aveva scaricato un secchio d’acqua inondando tutto il gruppo, compresi i tavolini, le sedie e
il divanetto a dondolo. Con lui si era arrabbiato, e anche tanto, il titolare del bar, omino generalmente
silenzioso, che a me pareva depositario di un passato che lo opprimeva o almeno preda di una depressione che non riuscivo, diciottenne com’ero, a contornare al meglio.
Era meravigliosa, piazza Fogliabella, e Grazia faceva parte di quello splendore, di quello stato di grazia,
se mi si concede la battuta. Era la più giovane, era la sorella minore più carina e simpatica che avremmo potuto desiderare. Magrolina, piuttosto piccola (ma diamine, aveva 14 anni e mezzo!), di carnagione chiarissima, occhi azzurri (o chissà se erano grigi), capelli castani tra il ricciolo e lo scompigliato.
Eravamo certi che sarebbe arrivata vestita di un sorriso, che avrebbe portato, ogni giorno, una ventata di
freschezza.
Spesso, nei decenni seguenti, qualcuno avanzò l’ipotesi che sarebbe stato bello ritrovarsi, magari allo
scoccare del quarantesimo anniversario da quel 1978, proprio al bar 2000, che dopotutto aveva continuato a esistere, gestione dopo gestione, quasi miracolosamente, e senza più cocorite in agguato. Attenzione, dichiarava qualcun altro, siamo invecchiati e c’è il rischio di ritrovarsi in un’apoteosi di rughe, di capelli grigi, di pance prominenti, stempiature e sederi raddoppiati, a chiedersi dove sia finita la più bella della compagnia, lei che quando si abbassava non si curava che la polo slacciata liberasse un paio di seni perfetti, abbronzati e dai capezzoli carnosi; o quello che ostentava la professione di sciupafemmine e che adesso fatica a nascondere il doppio mento; o quell’altro, dalla faccia rubiconda, ora coperta da una folta barba grigia; e che dire di molti di noi, dei capelli che avevamo, di criniere sparite per sempre? Ci
saremmo ricordati di ogni nostro assurdo soprannome, coniato a giugno e tramontato già in settembre?
Nomignoli come Topo, l’Infido, lo Scuro, Cicalino, il Nonno o l’Astruso, che sembravano uscire da un
film comico toscano? Avremmo riso come allora a snocciolare gli appellativi affibbiati alle ragazze, che a
seconda di caratteristiche somatiche o comportamenti reiterati venivano chiamate l’Ombrosa, la Diabolica, la Chiassosa, Grondaia oppure, senza un perché, la Melo?
Così quel ritrovarsi non ebbe mai luogo e nessuno fece parola del motivo più importante: non ci sarebbe
stata la Grazia a raccontare la sua versione, i suoi ricordi, le sensazioni a distanza di così tanto tempo.
Quando ascolto una certa canzone e libero la mente per spingerla all’estate del 1978, mi ritrovo in una
vecchia casa, non abitata, di un banale paesino a pochi chilometri dalla mia città, dove per una manciata di pomeriggi ci trasferimmo perché qualcuno aveva proposto di farci un clan, tra quelle quattro mura con
cortile. Ancora il clan – avevo pensato io – come tre inverni prima.
Era rimasta un’ossessione, il clan.
Uscì l’idea di scucire diecimila lire a testa (o forse erano ventimila?) per pagare una sorta di affitto ai
genitori di uno di noi, proprietari di quella casa che sembrava più un avamposto che un rifugio. Saremmo
stati più comodi, avremmo ascoltato musica, cantato a squarciagola e urlato come non mai. C’era
trambusto nel giorno della perlustrazione, dal nulla spuntò una scopa da far roteare e volare e finì che il
manico urtò violentemente il ventre di Grazia.
Il giradischi cantava Wuthering Heights di Kate Bush mentre Grazia accusava il colpo sorridendo. Chissà
che dolore sentiva, era piegata in due, il viso le si era arrossato, noi che eravamo abituati al pallore della
sua pelle ci spaventammo ma lei sorrideva, come se non volesse far preoccupare quei ragazzacci che, per
sdrammatizzare, cominciarono a ripetere, con tono isterico, quanto fosse forte la Grazia. La puntina arrivò
all’ultimo solco delle cime tempestose di Kate Bush, il colorito di Grazia ritornò al colorito abituale e noi
di quelle dieci o ventimila lire non sapemmo più niente, uscirono dalle nostre tasche per non farne più
ritorno e senza avere un clan campagnolo dove far roteare manici di scopa.
Il beneficiario mugugnava qualcosa, rimandava, masticava parole.
Rimase, quella, l’unica vera macchia di un’estate che vide rane catturate e depositate sotto la pedaliera di
una A112; una pazza estate, teatro di un’impennata fallita su una Vespa altrui così chi guidava, per salvare
la carrozzeria, rimase attaccato alle manopole strisciando le ginocchia sull’asfalto per decine di metri
inseguito dalle nostre urla; un’estate di campionati del mondo di calcio che ci parvero una cocente
delusione solo perché non potevamo ancora sapere del trionfo in quello successivo; un’estate profumata di tigli alla sera, di giri sulle Vespa Primavera o ET3 o sui più grandi Px tra le colline, tutti senza casco
perché in quegli anni andava così, capelli al vento della notte e ragazze quindicenni aggrappate alle nostre maglie; era un’estate speranzosa, con i suoi fogli rosa che presto sarebbero diventati patenti, per sognare bastava salire sulla Escort arancione di Topo o sulla vecchia Fiat 600 di Luciano, lui che quando rideva assomigliava a Fernandel, loro che avendo un anno in più già guidavano e quei giri diventavano così momenti indimenticabili; un’estate in cui esili ragazze venivano portate di peso, urlanti, nella lavanderia che si affacciava sulla piazzetta e depositate direttamente sul banco, intanto la titolare non si arrabbiava nemmeno troppo e alla fine ci rideva sopra; un’estate in cui bastava distrarsi per ritrovare il proprio motorino dentro un cespuglio o, peggio ancora, nascosto in un cortile lontano; un’estate comica,
clamorose dichiarazioni d’amore che facevano fuggire da una panchina nascosta nel verde, sguardo
sconsolato di lui, mani tra i capelli per lei e risate crudeli dei testimoni.
Perdo il senso del tempo, davanti alla tomba che sorride.
Potrei giurare di esser stato raggiunto, tra un refolo d’aria freddo e uno scalpiccio nella ghiaia, da qualche
nota di Wuthering Heights, che quell’estate, nonostante avessi cominciato ad amare hard rock e rock

progressivo nella stessa misura, diventò per me la canzone che meglio impressionò quattro mesi incisi
nella storia della nostra gioventù. Sarà per la voce particolare di Kate Bush e per quel suo modo di cantare
che così non si era ancora sentito, sarà che l’associo all’incidente della scopa e al sorriso di Grazia
nonostante tutto.
L’estate del 1978 finì, qualcuno di noi nei mesi successivi scrisse una sorta di diario di quelle gesta
eroiche che fu letto durante una festa di compleanno, a dicembre. Una mia felicità postuma vorrebbe
ricordare tutti i presenti in ascolto, concentrati e pronti a esplodere in una risata, a prendersi in giro, ad
aggiungere aneddoti magari tralasciati. Ma non andò così, ci fu piuttosto una distrazione di massa che
celava imbarazzo, che faceva intravedere, almeno in alcuni, un triste disinteresse.
L’estate del 1978 finì, dunque. Ne seguirono altre tre in piazza Fogliabella se non ricordo male, ma
nessuna fu speciale come la prima. In mezzo ci furono stagioni diverse che fecero nascere e morire storie
d’amore, addirittura allontanare quelle che ci erano sembrate amicizie inossidabili; le ragazze emigravano
verso altre compagnie, attirate dal belloccio in voga che non le avrebbe mai degnate di uno sguardo o per dare inizio a legami che sarebbero durati nel tempo. Come le cime tempestose di Kate Bush, quegli anni erano un mondo in ebollizione, ma noi non ce ne rendevamo conto. Una continua evoluzione in cui
potevamo essere vittime come carnefici, per quanto possano sembrare estremi questi termini.
Perdemmo di vista anche la Grazia.
Vorrei dirle che, almeno per me, quello fu un grande dispiacere, ma è difficile trovare le parole giuste
davanti a una lapide. Nella fotografia lei tiene la testa appena piegata verso destra e quel sorriso che
sembra fronteggiare una frase scherzosa detta da chissà chi. Porta una canotta nera la Grazia, una canotta
che lascia scoperte spalle che non hanno ancora detto addio all’adolescenza.
I suoi occhi luminosi sembrerebbero accettare un dialogo tra mondi diversi, ma sono io a non esser
pronto, così la saluto muovendo appena una mano e mi incammino verso l’uscita del cimitero
fantasticando sul suo paradiso personale, immaginandolo a forma di una piccola piazza di periferia, al sole di un’estate senza fine.
E sorrido.












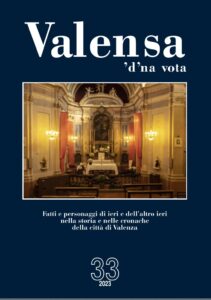








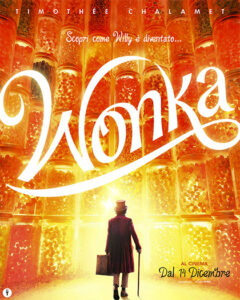







+ There are no comments
Add yours